Gentilissima Dottoressa Menghini, noi di Aleteia l’abbiamo contattata per avere da lei un parere circostanziato e fondato sul presunto boom di DSA. Su varie testate giornalistiche e nei servizi dei TG ricorrono spesso servizi che, se da un lato espongono il problema descrivendo la realtà di questi disturbi del neurosviluppo, dall’altra lasciano intendere che si tratti di eccesso di diagnosi, di trend, quasi di una moda.
La prima domanda è questa: davvero in Italia si può parlare di boom, o meglio di un vero e proprio eccesso, di queste diagnosi?
Assolutamente no, non si può parlare di boom. In Italia, dove la lingua è una fra le più trasparenti, dove cioè la corrispondenza tra grafema e fonema è altissima (scrivo A e leggo A) ci si aspetta circa un 3% di bambini con DSA.(Lo studio epidemiologico indicato nel link conclude che il fenomeno, in Italia, è stato a lungo e largamente sottostimato, Ndr). Analizzando gli ultimi dati disponibili del MIUR, nell’anno scolastico 2015/2016 si rilevava la presenza di 219.147 alunni con DSA, ovvero il 3% del totale degli alunni, contro il 2,1% del 2014/2015. Nei paesi anglosassoni, che hanno una lingua cosiddetta opaca, si arriva anche al 17% di bambini con DSA. Stiamo quindi raggiungendo i livelli di incidenza attesa, sebbene siamo partiti in ritardo e gli studi epidemiologici siano ancora molto sporadici. Va sottolineato però (si veda il sito dell’Associazione Italiana Dislessia ) che la situazione è squilibrata nelle diverse Regioni d’Italia con un probabile eccesso di diagnosi al Nord e una sottostima del fenomeno al Sud. Sottostimare il numero dei bambini con DSA è molto pericoloso. Esiste infatti un fattore di co-morbilità molto ricorrente legato alla non tempestività della diagnosi: fino a che il bambino non capisce e non si sente capito rispetto a ciò che deve affrontare può soffrire livelli importanti di frustrazione, di ansia e addirittura manifestare comportamenti di ritiro o aspetti di depressione.

Leggi anche:
La tragedia silenziosa che sta colpendo i nostri bambini, oggi
I DSA non c’entrano con i livelli di intelligenza?
No. Anzi, si può fare diagnosi di DSA solo nel caso in cui l’intelligenza è pienamente adeguata. Leggere male o non sapere le tabelline non vuol dire affatto avere poche capacità logiche e di ragionamento. Ma fino a che il bambino non è aiutato a distinguere le due cose e a dirsi “leggo con tanta fatica, questa cosa mi riesce male, ma sono intelligente perché posso capire e ragionare come gli altri compagni” può sentirsi inadeguato e non capace a causa delle prestazioni scolastiche scadenti. Riconoscere la difficoltà di apprendimento rassicura generalmente il bambino e gli permette di capire che non dipende da lui. Anche gli stessi insegnanti o i genitori, fino a che non comprendono che esiste una difficoltà oggettiva, possono involontariamente colpevolizzarlo. I genitori soprattutto non hanno gli strumenti per riconoscere queste specifiche difficoltà: vedono il loro bambino comunque intelligente e non riescono a capacitarsi delle prestazioni scadenti. Oppure incostanti: “a volte il dettato riesce bene a volte no…ma allora lo fa apposta?”. Di fronte a queste frequenti frustrazioni è facile che il bambino metta in atto strategie di evitamento, di rifiuto dei compiti che sente troppo ardui per lui. La diagnosi può essere effettuata al termine del secondo anno della scuola primaria per la dislessia e la disortografia e al termine del terzo anno per la discalculia.
Infatti spesso anche i genitori più bendisposti e dotati di pazienza sono destabilizzati di fronte al proprio bambino con DSA. Cosa non capiamo?
Nel bambino con DSA ciò che è altamente deficitario è l’automatizzazione della lettura, del calcolo della scrittura. Per chi non ha questi disturbi, una volta consolidate le associazioni segno-suono, la lettura diventa automatica, così come scrivere senza errori ortografici o ricordare le tabelline. Attività che non richiedono più continua attenzione e concentrazione. Esistono però diversi strumenti compensativi e misure dispensative, soprattutto nella scuola secondaria inferiore, che consentono agli studenti con DSA di fare meno fatica nell’apprendimento, come il computer per scrivere o i formulari per ricordare le regole di matematica. A volte gli studenti però sviluppano una forte resistenza nei confronti di questi strumenti per la necessità di non sentirsi “diversi”. Li rifiutano pur avendone bisogno: allora serve soprattutto un sostegno emotivo da parte degli insegnanti e dei genitori per accettarli, perché consentono ai ragazzi di raggiungere i risultati degli altri, con un riscontro positivo in termini di autostima. Spesso il costo emotivo e la ridotta autostima compromettono ulteriormente le prestazioni ma se, ad esempio, l’uso del tablet in aula non fosse consentito solo agli studenti che fanno errori ortografici ma potesse essere utilizzato da tutti, allora il bambino con DSA non avrebbe più ragione di sentirsi diverso dagli altri. Non andrebbe stravolta la didattica, solo adattata. La scuola devo dire che si sta muovendo in questo senso e la tecnologia, se ben utilizzata, può aiutare parecchio.
Gli studenti con DSA sono quelli che anche solo 15-20 anni fa erano i nostri compagni etichettati come pigri e fannulloni?
Spesso è così, soprattutto perché allora non avevamo a disposizione gli strumenti (i test) per valutare oggettivamente le difficoltà di apprendimento. Pensiamo alla nostra carriera scolastica. Ci verranno in mente compagni che non erano affatto poco intelligenti ma che a leggere facevano sempre una grande fatica, ad esempio, e con tutta probabilità venivano rimproverati per scarso impegno.
La scuola come si sta muovendo rispetto ai DSA?
Alcune sono attrezzatissime sia per i DSA sia per i BES (Bisogni Educativi Speciali) e sono equipaggiate ad intercettare nei propri studenti gli indici di rischio di una difficoltà. Secondo la legge 170/2010 e le note attuative dovrebbe essere la scuola ad individuare bambini con difficoltà di apprendimento, a mettere in atto attività di recupero e di potenziamento e a segnalare ai genitori solo i bambini in cui permangono le difficoltà nonostante le attività proposte per recuperarle. Il DSA in sé oggi non è più un problema e a volte non serve una vera e propria terapia. Il bambino può apprendere con efficacia grazie all’introduzione e all’uso adeguato di strumenti di supporto: la proposta di schemi e mappe concettuali, l’uso del tablet, ad esempio. Soprattutto quando i bambini con DSA sono alla fine della primaria non serve più una vera e propria terapia riabilitativa. Si usano strumenti di facilitazione che possono essere impiegati a qualsiasi età (anche gli studenti universitari ne possono usufruire). Ci sono poi in Italia ottime sperimentazioni. Ad esempio, quelle delle flipped class per l’insegnamento capovolto, in cui è stato introdotto per tutti l’uso del tablet – misura che risolve anche il problema dell’enorme carico di libri che riempiono gli zaini dei nostri figli all’inverosimile…ndr, (il metodo delle flipped class consiste nell’invertire il luogo dove si segue la lezione, a casa propria anziché a scuola, con quello in cui si studia e si fanno i compiti. L’insegnante fornisce agli studenti materiali didattici appositamente selezionati, predisposti da egli stesso o da altri. I materiali didattici possono essere video, risorse multimediali, libri o e-book. Gli studenti studiano guardando i video e consultando i materiali più e più volte, ciascuno secondo le proprie esigenze, prima e al di fuori della scuola, e non dopo, come nel modello classico. Per approfondire, qui)

Leggi anche:
Flipped classroom, o come invertire il metodo di apprendimento
Cosa significa concretamente avere un DSA? Cosa implica nella vita di uno studente?
Al di là della constatazione “leggo o scrivo male” la domanda da porsi è: quanto questa difficoltà interferisce con la vita quotidiana dello studente? Se questo problema determina limiti importanti soprattutto sul fronte psicologico ed emotivo allora si interviene. Così dice anche il DSM 5, il manuale per la valutazione dei disturbi mentali: occorre valutare l’impatto funzionale del disturbo e non solo il disturbo in sé stesso. In particolare, posso leggere male ma avere un rendimento scolastico alto, essere autonomo nei compiti, comprendere i testi che legge, vivere serenamente l’apprendimento. Allora il problema non si crea. Ecco un rischio che posso ravvisare nell’approccio di alcuni specialisti. E’ che sono troppo “tecnici” nella valutazione, contando solo, ad esempio, quanti errori il bambino compie o quale è la velocità di lettura. Occorre a mio avviso, invece, vedere sempre la reale compromissione che il DSA determina nella vita quotidiana del bambino. Non il solo disturbo di lettura. Ecco, credo sia importante che sempre più specialisti abbiamo chiaro il criterio dell’interferenza nel funzionamento. Spesso ci si limita a conteggiare gli errori e/o la velocità di lettura.
Cosa pensa sia importante fare nel prossimo futuro per migliorare l’approccio ai DSA da parte del sistema scuola-famiglia-specialisti?
Credo che innanzitutto il problema vada demedicalizzato. Venti anni fa rappresentava effettivamente un impedimento all’apprendimento. Ora gli insegnanti possono supportare l’apprendimento dei bambini con DSA senza che le loro difficoltà interferiscano, utilizzando numerose strategie e metodologie! Perdurano invece approcci pedagogici che non hanno alcuna base scientifica e che continuano a penalizzare gli studenti con DSA. Ad esempio, dagli anni’80 si utilizza per l’insegnamento della letto-scrittura il metodo “globale”, dalla frase alla parola al suono. Ma non ha alcun senso applicarlo nella nostra scuola perché la lingua italiana, come ho già sottolineato, presenta un’alta corrispondenza fra suono e lettera scritta (ad esempio, non è ambigua come la lingua inglese). Un bambino non a rischio DSA impara lo stesso a leggere e a scrivere, nonostante il metodo globale. Un bambino con difficoltà di apprendimento invece sarà ulteriormente intralciato e comprenderà il meccanismo di corrispondenza lettera/suono ancora più tardi. Chi ha difficoltà analizza male i suoni e in questo modo si rende ancora più difficoltoso il processo.
Altro problema: i sussidiari sono in qualche modo ostili a chi manifesta difficoltà di apprendimento. L’impaginazione, i caratteri, l’interlinea e la spaziatura non sono sicuramente pensati per facilitare la lettura. Ad esempio, l’allineamento giustificato crea difficoltà nel ritrovare il segno mentre il semplice sfalsamento delle righe sarebbe di grande aiuto. Le righe e le parole maggiormente distanziate favorirebbero tutti i bambini, non solo chi ha un DSA. Esistono testi ad alta leggibilità ma ancora non sono così diffusi. (Un suggerimento banale per i genitori potrebbe essere di richiedere i CD-Rom dei testi e modificare l’allineamento, la grandezza del carattere, la distanza fra le righe, fra le parole e le lettere per favorire la lettura dei testi).
Il processo di apprendimento spesso non è adeguatamente conosciuto da molti insegnanti. Come avviene l’apprendimento della lettura nel bambino secondo uno sviluppo normale?
In età prescolare, all’ultimo anno di scuola per l’infanzia, il bambino è in grado di riconoscere le sillabe che compongono le parole udite e di ripeterle. Dire “ma- re” sentendo “mare” o viceversa indovinare “pane” ascoltando le sillabe “pa-ne”. Entro la fine del primo anno della scuola primaria generalmente chi non ha difficoltà riesce ad individuare oralmente i singoli suoni (fonemi) che compongono le parole: dire “m-a-r-e” sentendo “mare” o viceversa dire “pane” ascoltando i singoli suoni “p-a-n-e”. Chi è più in grado di svolgere questi esercizi incontra meno difficoltà nell’apprendimento della letto-scrittura. La “sintesi” dei singoli suoni è particolarmente implicata nella lettura e la “segmentazione” nei singoli suoni invece nella scrittura. Piano piano i bambini capiscono che per leggere correttamente alcuni suoni (ad esempio, la C) devono vedere la lettera che c’è dopo (la “i” o la “a”) o leggere insieme gruppi di lettere (la “gl”, “sch”). Questo processo, che consiste nell’accorpamento di più lettere, si sviluppa progressivamente e nel terzo o quarto anno della scuola primaria si leggono nella loro interezza le parole più frequentemente incontrate. Leggere e scrivere diventano così processi automatici. Se ciò non avviene, la letto-scrittura continua a richiedere elevate risorse attentive e non appena l’attenzione si riduce la prestazione si fa scadente. Non è che i DSA non sappiano leggere o scrivere. È che farlo richiede loro uno sforzo notevolmente superiore rispetto ai compagni e continua attenzione. Per questo spesso hanno reazioni di rifiuto: misurarsi con un’attività che richiede notevole sforzo spesso determina un atteggiamento di sfiducia e un’immagine scadente di sé. È importante quindi ribadire frequentemente ai bambini con DSA che è la loro lettura o scrittura non sono fluide e “automatiche” come per gli altri bambini, ma che questo non ha niente a che vedere con le loro capacità logiche o di apprendimento.
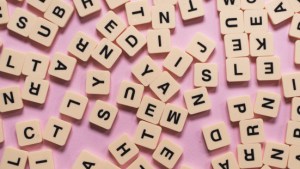
Leggi anche:
Cosa provoca la dislessia? La risposta potrebbe essere negli occhi
Da cosa dipendono i DSA?
Come gli altri disturbi del neurosviluppo, i DSA hanno una base neurobiologica. La ricerca scientifica ha più volte documentato che alcune regioni cerebrali implicate nei processi di lettura si attivano in maniera diversa rispetto ai normolettori. Generalmente le regioni cerebrali posteriori sono risultate ipoattive durante compiti di lettura.
Se dovesse darci una lista sintetica sul tema DSA e scuola?
- Attenzione a fattori di rischio in età prescolare (ritardo di linguaggio, ridotte capacità verbali, difficoltà nella coordinazione e nell’attenzione)
- Attenzione al metodo di insegnamento (evitare il metodo globale o misto!)
- Conoscere i meccanismi di apprendimento
- Possibilità di vera e propria diagnosi DSA alla fine del secondo anno (per la lettura e la scrittura) e il terzo anno (per il calcolo) della scuola primaria
- Attenzione alla co-morbilità elevata, con l’ADHD, l’ansia o il ritiro e alle conseguenza emotive (bassa autostima, isolamento, rifiuto, malesseri fisici, …)
- Mettere in atto tempestivamente strategie che favoriscono l’autonomia del bambino con DSA (per l’applicazione autonoma degli strumenti compensativi e delle misure dispensative)
- Importanza della reale interferenza delle difficoltà di lettura, scrittura e calcolo con il processo di apprendimento: chiediamoci se il bambino mostra malesseri fisici in relazione alla scuola (mal di pancia, vomito, ansia), se le difficoltà riducono il rendimento, se il bambino non comprende ciò che legge o studia con alto dispendio di energie, se non è autonomo nei compiti.
- Non esiste una terapia riconosciuta scientificamente efficace per i DSA. Si procede per “buona prassi clinica”. Soprattutto è importante chiedersi quando è arrivato il momento di interromperla e di fornire strategie per supportare l’apprendimento in modo autonomo.
Possiamo concludere che ora la scuola e la famiglia sono più attente e pronte ad intervenire ma c’è ancora molto da fare.
