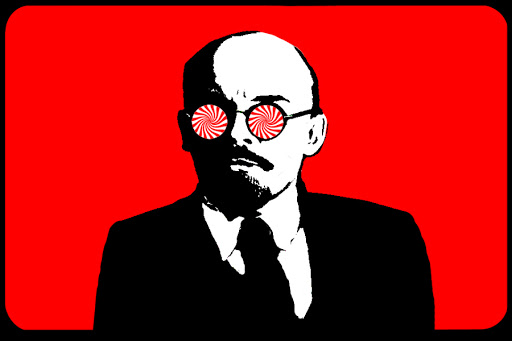di Jason Jones and John Zmirak
Come ha ammesso C. S. Lewis nella prefazione de Le lettere di Berlicche, può essere profondamente inquietante – perfino debilitante – per un autore prefiggersi il compito di esaminare il male dal di dentro. Come un'autopsia, è un compito spiacevole ma a volte necessario.
Lenin a Zurigo (1976), di Aleksandr Solzenicyn, effettua un'autopsia di questo tipo del socialismo marxista dal punto di vista dello stesso Nikolai Lenin. Il libro è stato pubblicato come un romanzo indipendente, anche se la sua narrativa, divisa in parti, appare anche nella serie epica di romanzi storici dell'autore, La ruota rossa. L'analogia letteraria più vicina sono Le lettere di Berlicche (e forse la Lolita di Vladimir Nabokov). Ciò che ha spinto Solzenicyn a condensare il suo vasto spirito perché potesse entrare nel brutto barattoletto che era la mente di un ideologo è stata la necessità di spiegare. La ruota rossa, infatti, è un tentativo di costruire una contronarrazione della storia del suo Paese, volta a opporsi ai resoconti prodotti dalle orde di storici occidentali che guardavano con simpatia al socialismo e che hanno insistito nel corso dei decenni a diffondere una lunga lista di miti su ciò che è avvenuto in Russia nel XX secolo.
La fantasia più popolare, durata al massimo malgrado l'inesorabile rilascio di prove del contrario, raffigura Lenin come un rivoluzionario fondamentalmente progressista, il cui tentativo di liberare la Russia è stato tragicamente dirottato dal teppista Stalin – che per i veri “credenti” non era neanche un vero marxista, ma semplicemente un bandito che ha adottato un'ideologia per coprire la sua sete di potere. Nessuno che legga delle repressioni di massa ordinate da Lenin o analizzi attentamente le lettere in cui questi saluta con gioia la notizia di contadini giustiziati per aver “accumulato” il proprio grano o degli uomini di Chiesa indifesi fatti morire di fame può accettare questo mito in modo innocente. Un unico telegramma inviato da Lenin nel 1918, ampiamente disponibile al pubblico, avrebbe dovuto essere sufficiente a mettere a tacere il mito per cui questi era semplicemente un “liberale frettoloso”. Come scrisse ai suoi subordinati l'11 agosto di quell'anno:
“Compagni! La sollevazione delle cinque volosts [regioni] dei kulaki deve essere soppressa senza pietà. L'interesse dell'intera rivoluzione lo richiede, perché ora stiamo affrontando dovunque la 'battaglia decisiva finale' con i kulaki. Dobbiamo dare un esempio.
1. Dovete impiccare (impiccarli, perché la gente veda) non meno di 100 dei kulaki famosi: i ricchi e le sanguisughe.
2. Pubblicare i loro nomi.
3. Togliere loro tutto il grano.
4. Stabilire gli ostaggi in base al telegramma di ieri.
Ciò deve essere fatto in modo tale che per centinaia di verste [unità di misura dell'impero russo] lì intorno la gente veda, tremi, sappia e gridi. Stanno soffocando, e soffocheranno i kulaki sanguisughe.
Telegrafateci informando su ricevuta e implementazione.
Vostro, Lenin.
PS. Trovate persone più dure”
Solzenicyn fa molto più di dichiarazioni documentali come questa. In Lenin a Zurigo, torna indietro a prima dell'improvvisa ascesa al potere di Lenin – come una zampa di gatto della Germania del kaiser, che era disposto a tutto per spingere la Russia imperiale fuori dalla guerra – per esplorare come un intellettuale dal grande talento, la cui politica era impeccabilmente “progressista”, potesse essere allo stesso tempo un dogmatista ristretto e amaro con la fredda voglia di uccidere civili disarmati a migliaia e di deportarne molti di più nei campi di internamento a morire di freddo o di fame. Nel romanzo, Solzenicyn raffigura i conflitti di Lenin con i socialisti rivali in esilio, che egli cercò di guidare con soprusi o lusinghe. Essendosi convinto di essere arrivato all'unico piano d'azione plausibile per mettere in pratica il marxismo, considerava chiunque avesse un'idea diversa perfino sulle tattiche come un sabotatore. La tattica di Lenin, come ripeteva sempre, era “dividere il partito” finché non avesse eliminato chiunque non fosse totalmente docile. Ciò che rimaneva erano i superstiti di una fazione, che nel 1917 fuggirono in esilio in Svizzera lasciandosi dietro pochi legami in Russia. Mentre la narrazione procede, Lenin appare sempre più come un fanatico teorico di cospirazioni che trascorre i suoi giorni inutilmente tiranneggiando una banda di fanatici e di seguaci servili ormai in calo. Sembra poco plausibile che un uomo di questo tipo sia arrivato a gestire un posatoio, e la terribile consapevolezza del fatto che presto otterrà un potere assoluto di vita e di morte su un vasto impero continentale imbeve il romanzo di un'ironia quasi insopportabile. Leggerlo è come guardare un autobus pieno di rifugiati innocenti cadere in un dirupo, in un rallenty straziante.
Al di là dei piani machiavellici di uomini come il generale tedesco Erich Ludendorff (che in seguito sosterrà Hitler contro la minaccia bolscevica che egli stesso aveva scatenato), quindi, cosa spiega l'ascesa di Lenin come dittatore? È, come suggerisce Solzenicyn, proprio il suo dogmatismo, la sua salda sicurezza settaria della rettitudine delle proprie azioni. In una Russia la cui l'intellighenzia liberale conosceva solo una cosa per certo – non ci sono nemici a sinistra –, non c'era alcun partito coerente che rappresentasse la riforma moderata. Il prudente ministro modernizzatore Pyotr Stolypin, che serve da eroe tragico di tutta l'epica di Solzenicyn, era stato assassinato anni prima, e i suoi sostenitori erano stati estromessi dal potere. Il regime dello zar era difeso solo dai bigotti, timidi o venali, mentre coloro che chiedevano le riforme erano così insaziabili nel volerlo detronizzare e nel cancellare la storia russa che nessun radicale a sinistra avrebbe mai potuto sembrare pericoloso.
Aleksandr Kerensky, che aveva formato il Governo provvisorio dopo l'abdicazione di Nicola II, fece poco per ostacolare le mosse ovvie di Lenin verso la conquista del potere militare. Quando socialisti meno radicali guardavano ai loro colleghi più fanatici, ciò che provavano non era una paura prudente, ma una sorta di cattiva coscienza – quasi come se la loro moderazione fosse una prova di codardia. I lettori del Radical Chic di Tom Wolfe riconosceranno questo modello psicologico, ricordando Leonard Bernstein che ospitava le Pantere Nere criminali e antisemite nel suo elegante appartamento newyorkese. Nel corso degli anni Settanta, le élites europee di sinistra avrebbero mostrato la stessa indulgenza con le Brigate Rosse, l'OLP e la banda Baader-Meinhof, come documenta Michael Burleigh in “Blood and Rage: A Cultural History of Terrorism”.
In un'epoca di irritante confusione, il potere è caduto nelle mani dell'uomo che aveva un progetto e un culto posseduto dalla certezza assoluta e dogmatica – un uomo la cui visione di trasformazione era così assoluta e semplicistica da poter essere compressa in pamphlet grossolani, rigurgitati come canti di guerra, ingeriti come uno stimolante, in un modo molto simile a quello in cui il radicalismo insondabile di Hitler avrebbe vinto la più lieve passione di altri nazionalisti tedeschi più razionali. Per usare una metafora visiva, la falce e il martello o la svastica sono molto più semplici da scarabocchiare per chi non ha talento nei graffiti di periferia rispetto agli emblemi più tradizionali di sistemi politici più complessi, come l'aquila prussiana o austriaca. Ideologie create da aspri intellettuali settari per far appello ai duri di strada e agli sfaccendati invidiosi avrebbero sostituito la filosofia politica in Occidente sull'onda della I Guerra Mondiale.
Gli innumerevoli crimini e il collasso finale dell'Unione Sovietica, ahimé, non hanno screditato del tutto la filosofia politica che questa ha messo fedelmente in pratica. Quasi nessuno oggi crede ancora nell'utopia marxista – una mancanza di fede che indebolisce parte dell'energia fanatica che una volta infondeva il comunismo. Per chiunque sia onesto, è chiaro cosa producono i movimenti marxisti quando arrivano al potere: un mastodonte burocratico statalista e pseudoegualitario che manipola le masse che mantiene ignoranti e garantisce la ricchezza a chi ha il potere. In altre parole, qualcosa di simile all'Italia di Mussolini – o alla Cuba di Castro, o al Venezuela di Chávez, o ancora alla Corea del Nord di Jong-Un. Quello che Marx definiva materialismo dialettico, messo in pratica, si riduce a quello che in 1984 Orwell definiva collettivismo oligarchico – la concentrazione di denaro e potere nelle stesse mani, che sono così protette dalla competizione sul mercato o sulla pubblica piazza. È questo che genera il marxismo, come il fascismo genera l'odio razziale e la guerra. E tuttavia ci sono persone che ancora sostengono il marxismo, anche se in un'acquosa forma “critica” o “revisionista” che si sottrae, sperano, alle macchie di sangue collezionate da quell'ideologia. A novant'anni dalla carestia ucraina, a ottanta dai processi per le epurazioni e a venticinque da quando il KGB ha aperto i suoi archivi di tortura, è il momento di smettere di fornire scuse a queste persone. Sanno cosa chiedono. Apparentemente, è ciò che vogliono.
[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]
Jason Jonesè un produttore di Hollywood. Tra i suoi film, Bella, Eyes to See e Crescendo. Per sapere di più delle sue iniziative sui diritti umani, www.iamwholelife.com.
John Zmirak è autore di The Bad Catholics Guide to the Catechism. I suoi articoli sono archiviati presso la The Bad Catholic’s Bingo Hall.
Questo articolo è tratto dal prossimo libro di Jones e Zmirak, The Race to Save Our Century (Crossroad, 2014).