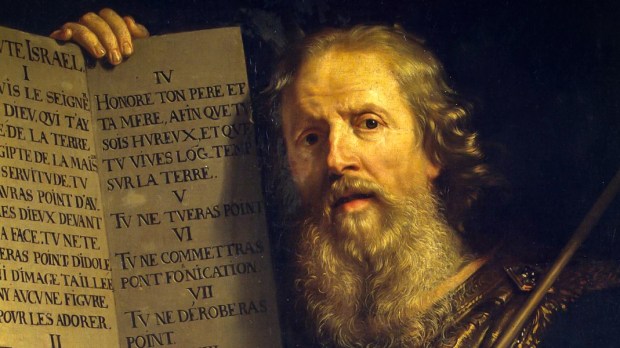Trovare i 10 comandamenti elencati in modo chiaro nella Bibbia è un compito difficile, se non impossibile, non perché siano cripticamente nascosti in qualche passo facile da trascurare, ma piuttosto perché ce ne sono tre versioni diverse. Una si trova nell’Esodo (20, 2-17), la seconda nel Deuteronomio (5, 6-21) e la terza nel Levitico (19).
A complicare le cose, tutte e tre sono organizzate ed esposte in modo piuttosto diverso. Trarne una lista chiara di 10 elementi è una questione delicata che richiede capacità ermeneutiche ed editoriali eccezionali.
È superfluo dire che in base al fatto che chi legge sia ebreo o cristiano (e ancor più in base al tipo di cristiano che è), questi “comandamenti” saranno numerati (ed espressi, interpretati e organizzati) in modo diverso. I Cattolici, ad esempio, ritengono che il primo comandamento implichi il fatto di non avere altri dèi né “idoli”. I Luterani sono d’accordo, ma altri Protestanti scindono questo comandamento in due parti, con la questione degli idoli che costituisce un comandamento in sé.

Le prime due versioni del Decalogo (Esodo e Deuteronomio) sono quelle con cui i lettori moderni hanno più familiarità. Parlando in senso ampio, sono relativamente simili, ma ciò non vuol dire che non differiscano l’una dall’altra su aspetti importanti. Nel Libro dell’Esodo, ad esempio, il comandamento dello Shabbat è relativamente “intellettuale” o “spirituale”. Nel Deuteronomio, è chiaramente più “fisico”. Il testo originale dell’Esodo dice “ricordare” (zkr, in Ebraico), mentre nel Deuteronomio si parla di “tenere” o “preservare attivamente” (shmr).
C’è sicuramente un aspetto pratico, “fisico”, da ricordare. Una persona ricorda facendo attivamente cose che aiutano a preservare un ricordo, ma la differenza “fisica” tra un testo e l’altro sembra più radicale quando andiamo avanti nella lettura. Nell’Esodo, la giustificazione per lo Shabbat è la storia della creazione in sette giorni: “Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato”. Anche se chi legge è disposto ad accettare che un Dio onnipotente potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo dopo aver creato l’universo, riferirsi a un “Dio stanco” potrebbe sembrare troppo. Come può il lettore misurare il grado di stanchezza di Dio? Come immaginare il “giorno libero” di Dio? Come possiamo imitare il Suo riposo? E inoltre, come intendere questo riposo, considerando che la Genesi non è pensata per essere analizzata in modo letterale? Come c’era da aspettarsi, le tradizioni rabbiniche (e cristiane) differiscono molto su questi aspetti.
Il Deuteronomio, dall’altro lato, si concentra su un aspetto particolare tratto dalla narrativa dell’esodo, la liberazione di Israele dalla schiavitù sotto il faraone: “ Ricòrdati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso”. Preservare attivamente nella memoria la severità e la crudeltà di un lavoro schiavo sembra aggiungere un orizzonte molto diverso (più immediato, meno “metafisico”) al comandamento.
È questa la differenza principale tra queste due versioni, ma non è sicuramente l’unica. Sia l’Esodo che il Deuteronomio recitano “Onora il padre e la madre”, ma il Deuteronomio aggiunge “come il Signore Dio tuo ti ha comandato”, mentre l’Esodo dice “affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà”. Il Deuteronomio include lunghe transizioni tra i comandamenti che seguono “Non uccidere”, mentre l’Esodo va direttamente da questo a “Non commettere adulterio”. Come spiega Kristin Swenson in A Most Peculiar Book: The Inherent Strangeness of the Bible, “desiderare moglie e abitazione hanno una priorità diversa nelle due versioni (l’Esodo pone l’accento sulla ‘casa’, il Deuteronomio sulla ‘moglie’), e il Deuteronomio aggiunge ‘il suo campo’”.
Altre differenze dipendono dal fatto che si renda “Io sono il Signore tuo Dio” il primo comandamento o meno. In generale, i cristiani dicono che non è un vero comandamento, perché non richiede alcuna azione da parte del credente. La tradizione rabbinica, dall’altro lato, sostiene che non è solo un ordine, ma piuttosto il comando in un senso più ampio. Se dobbiamo considerare il contesto storico in cui sono stati scritti questi testi (un contesto di dèi in competizione tra loro, in cui il monoteismo era ancora una rarità), riconoscere il Signore come l’unico Dio era un atto intenzionale, deliberato e spesso rischioso.
Forse più rivelatore di una lista accurata di differenze è il fatto che da nessuna parte nei testi biblici (né nell’Esodo, né nel Deuteronomio né nel Levitico) si usa la parola “comandamento”. Da nessuna parte nella Bibbia queste regolamentazioni sono identificate come tali. Il termine che usa il testo originale per quelli a cui la tradizione si è riferita come ai “comandamenti” è semplicemente “parola”. All’inizio del capitolo 20 dell’Esodo, il testo dice semplicemente “Dio pronunciò tutte queste parole”. È quello che il Decalogo traduce letteralmente – non “10 comandamenti”, ma “10 parole”.

In un’udienza del giugno 2018, Papa Francesco ha spiegato che l’uso di “parola” anziché di “comandamento” sottolinea la differenza tra ricevere un ordine e notare che qualcuno sta cercando di parlare con noi. Dà il tono per un rapporto dialogico tra chi parla e chi ascolta: i testi che comprendono il Decalogo mirano in primo luogo a istituire un rapporto tra Dio e il Suo popolo.
Francesco spiegava questo aspetto riferendosi al libro della Genesi, che intende in un rapporto tipologico con questi altri testi biblici. Il Papa ricordava come Satana abbia ingannato Adamo ed Eva proprio su questo punto: “Vuole convincerli che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell’albero del bene e del male per tenerli sottomessi. La sfida è proprio questa: la prima norma che Dio ha dato all’uomo, è l’imposizione di un despota che vieta e costringe, o è la premura di un papà che sta curando i suoi piccoli e li protegge dall’autodistruzione? È una parola o è un comando?”
In breve, considerare che il testo originale dice “parola” e non “comando” ci ricorda che, come ha spiegato il Papa, “il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola, invece, è il mezzo essenziale della relazione come dialogo”; “quando qualcuno parla al nostro cuore, la nostra solitudine finisce. Riceve una parola, si dà la comunicazione e i comandamenti sono parole di Dio: Dio si comunica in queste dieci Parole, e aspetta la nostra risposta”.