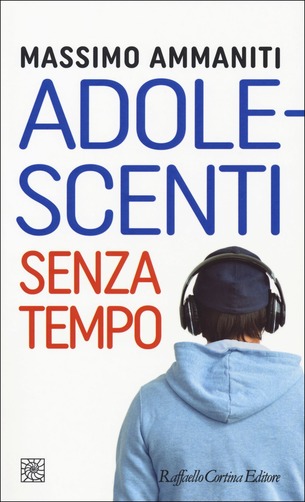Un recente libro del professor Massimo Ammaniti dal titolo: “Adolescenti senza tempo” (Raffaello Cortina Editore) affronta la delicata tematica dell’odierna adolescenza alla luce delle rapide trasformazioni socio-culturali intervenute nella società occidentale e i suoi riflessi nella realtà delle famiglie, cercando di offrire degli spunti utili ai genitori per comprendere ed interagire meglio con i loro figli, aiutandoli così nella loro ricerca dell’identità adulta.
SOS: pubertà in arrivo!
Quando i figli e le figlie entrano nella pubertà, cambia lo scenario della loro esistenza, ma contemporaneamente anche quello di tutta la famiglia. Papà e mamma assistono sorpresi, e spesso un po’ spaventati, al fatto che il loro bambino, la loro bambina si trasforma, spesso tumultuosamente, davanti ai loro occhi: non sono più quelli di prima, quando nell’infanzia si era creata una rassicurante intimità fisica fra genitori e figli, il cui corpo era percepito quasi come un’estensione di quello degli adulti. Con la pubertà si viene a determinare un progressivo aumento della distanza fisica oltre che emotiva fra di loro: agli occhi dei genitori il corpo del figlio appare ora quasi estraneo e, specie all’inizio, stentano a riconoscerlo in quanto non corrisponde più a quello a cui rivolgevano la loro protezione e tutte le loro premure. Anche per i figli inizia il momento dello sconcerto e dell’apprensione per un corpo che comincia a dare segnali che non si è abituati ad interpretare, e ad esplodere di una prorompente energia che non si è in grado di controllare. Un’immagine che può rendere in qualche modo questo vissuto è quella del principiante che inizia ad imparare a guidare, pervaso da un misto di timore ed eccitazione di fronte alla potenza del motore che ha fra le sue mani ed i suoi piedi.

Leggi anche:
8 tratti dell’adolescenza che ogni genitore deve conoscere
La pubertà di oggi e di ieri
La pubertà dei ragazzi di oggi inizia prima di quella dei loro nonni e degli stessi genitori, se pensiamo che all’inizio del XX secolo cadeva intorno ai 16-17 anni mentre attualmente prende avvio dagli 11-12 anni. A questa accelerazione dello scatto puberale hanno contribuito l’alimentazione più ricca di proteine, il migliore tenore di vita in generale e l’aumentato livello di istruzione, a significare come i processi biologici e la maturazione stessa del cervello risentano fortemente delle caratteristiche socio-culturali dell’ambiente in cui si vive. Ai tempi dei nonni, ma anche di genitori non giovanissimi degli attuali adolescenti, la società prevedeva dei “rituali di passaggio” collegati alla pubertà che aiutavano adulti e ragazzi ad affrontare questo complesso momento esistenziale. Infatti i maschi indossavano da bambini i “calzoni” corti, alla pubertà i pantaloni alla zuava fino al polpaccio, per arrivare a vestire i tanto desiderati pantaloni lunghi con l’ingresso nell’età adulta. Analogamente per le femmine si passava dai calzini di cotone dell’infanzia, alle calze di seta dell’inizio della pubertà, ed infine a quelle di nylon che segnavano l’avvenuta maturazione sessuale. Oggi la società non prevede rituali di passaggio,e per gli adolescenti questo aumenta le difficoltà ad affrontare questa fase dello sviluppo.
Genitori avvisati … ma per niente attrezzati
Per cogliere meglio la prospettiva dei genitori in questo frangente, il seguente passo dell’autore risulta illuminante:
Dopo una vita di condivisione quotidiana, i genitori hanno la certezza di conoscere i propri figli, di poter intuire i loro umori e guidare il loro carattere. Sanno che cosa aspettarsi, perlomeno hanno sempre creduto di saperlo, ed è stato così per molti anni. Sanno che la bufera è alle porte, che arriverà a sconvolgere i rapporti dentro la famiglia, trasformando il clima che si respira ogni giorno. Nelle occasioni in cui si incontrano con altri genitori, capita spesso che qualcuno paventi l’arrivo dell’adolescenza, e così vengono in qualche modo avvertiti. Sanno che succederà e, nonostante la preoccupazione, pensano di poterla affrontare, di poter superare gli inevitabili scogli. E invece no. L’adolescenza dei figli è un evento improvviso e inquietante, al quale i genitori arrivano invariabilmente impreparati. Non c’è manuale che tenga: è un passaggio difficile da gestire, per i genitori e per i figli. Èsempre stato complicato, ma oggi questa transizione ha acquisito tratti speciali, inediti e a volte tempestosi. L’adolescenza irrompe, ed è come se introducesse d’un tratto proprio quella distanza tra genitori e figli che si erano illusi di non aver creato con i comportamenti degli anni passati insieme.

Il distacco
Mediamente allo scoccare dei 12 anni i genitori cominciano ad avvertire la resistenza dei figli, la mancanza di interesse per momenti e attività prima condivisi. Non sono abituati alla freddezza, al rifiuto dei loro ragazzi, al fatto che non vogliono più saperne della loro compagnia fino ad arrivare a mostrare imbarazzo per la vicinanza fisica, riluttanza a scambiare tenerezze, a porre sulla porta della stanza il cartello con la scritta: non disturbare.
I desideri dei genitori non sono più i loro desideri. I giudizi dei genitori non sono più, necessariamente, i loro giudizi.
E questo disallineamento si estende a macchia d’olio investendo i gusti di ogni genere, le idee sulla politica, le convinzioni religiose, gli argomenti di carattere etico, dove spesso gli uni e gli altri si vengono a trovare su posizioni diametralmente opposte.

Leggi anche:
Adolescenza ed emozioni negative: niente paura!
La rivendicazione di autonomia
Il contrasto continuo è principalmente centrato intorno al bisogno dell’adolescente di sentirsi autonomo e soddisfare i propri desideri senza renderne conto a nessuno.
Gli scontri e i contrasti fra genitori e figli si incentrano principalmente sull’orario del rientro a casa: infatti, i ragazzi, quando escono la sera, vorrebbero sentirsi liberi e non dover comunicare a che ora torneranno. Fuori dalla cerchia familiare, il tempo viene scandito dal gruppo di amici o dall’incontro sentimentale e per i ragazzi diventa difficile, se non impossibile, comunicare quando torneranno a casa oppure se faranno tardi. Anche perchè non ci si può dimostrare dipendenti dai genitori agli occhi degli amici: sarebbe un grave scacco all’autostima. I limiti imposti dai genitori vengono percepiti dagli adolescenti come una ferita inaccettabile al proprio narcisismo; non riescono a comprendere la preoccupazione dei genitori, e si convincono che non abbiano fiducia in loro e per questo continuino a controllarli.
La grammatica adolescenziale: che fatica!
Se durante l’infanzia per i genitori non era difficile interpretare la “grammatica” dei comportamenti e delle reazione dei figli, adesso provare a farlo è una missione quasi impossibile a causa della loro mutevolezza ed imprevedibilità.
È difficile, per i genitori, trovare la distanza giusta e l’atteggiamento emotivo adeguato nei suoi confronti: anche loro risentono degli alti e bassi del figlio, e li riflettono. Si verificano spesso cortocircuiti, in cui tutta la famiglia è coinvolta, anche se, spesso, è la madre – o anche il padre – a cercare delle mediazioni. È faticoso tentare di capire ogni volta quando il figlio abbia bisogno di interagire, addirittura di essere rassicurato, e quando, al contrario, senta la necessità di starsene per conto suo.

Leggi anche:
Il cervello degli adolescenti è un campo di battaglia, non lasciamoli soli
Crisi che si incrociano sommandosi
Ma se i figli adolescenti subiscono trasformazioni importanti anche i loro genitori sono costretti a fare i conti con l’avanzare dell’età – e la minore vitalità e spensieratezza che generalmente comporta – e con l’insicurezza generata dal venir meno dei modelli educativi di riferimento.
Ecco che i genitori, insicuri e in piena crisi di identità, legata alla mezza età, si trovano a loro volta, al pari dei figli, <in mezzo al guado>. Quando ci si avvicina ai 50 anni o li si supera, si avverte più o meno consapevolmente che l’età giovanile si è conclusa e si cominciano a fare i primi bilanci della propria vita: se si è realizzato quello che si desiderava oppure se si è delusi perché si è presa una strada diversa da quella cui si aspirava. Èa questo punto, nel mezzo di questa crisi della mezza età, che si intravedono i primi segni dell’invecchiamento: qualche capello bianco, il seno che si appesantisce, qualche chilo in più e, soprattutto, il venir meno delle illusioni e delle aspettative giovanili. Il percorso dei genitori di figli adolescenti e quello dei loro ragazzi s’incrociano. Si tratta di crisi di identità diverse: quella dei figli è legata alla difficile costruzione del proprio Sé e alla ricerca di una direzione personale che li faccia uscire dall’impasse in cui si trovano; quella dei genitori è legata al riconoscimento del percorso compiuto e dell’inevitabile bilancio alla luce delle passate aspettative. La confusione degli uni e degli altri si sommano, facendo perdere di vista lo scenario familiare per cui ognuno, più o meno segretamente, si ritira in se stesso.
Dalla famiglia padrona a quella adolescenziale che tutto concede
La fragilità degli adulti di questo periodo rischia di comportare la sensazione che l’identità ed il valore del loro ruolo genitoriale dipendano in misura preponderante dall’approvazione filiale, con il rischio di un capovolgimento del rapporto: nei casi più problematici si viene a configurare una relazione quasi di sudditanza dei genitori rispetto ai figli.
Si è passati, così, da un eccesso all’altro: dalla famiglia padrona alla famiglia assoggettata ai capricci e ai risentimenti dei figli. Meglio cedere ai desideri del figlio che sostenere terribili e inconcludenti litigate (…) I genitori sono spesso prigionieri delle richieste e dei ricatti consumistici dei figli, che aiutano a sedare l’ansia e a creare la sensazione che si stia cercando di esaudire i loro desideri.
Ecco che così si configura l’esatto contrario di ciò di cui gli adolescenti hanno bisogno: confrontarsi con adulti stabili, convinti delle loro idee, in grado di assolvere in modo fermo e coerente il loro ruolo educativo. Infatti i giovani possono imparare a riconoscere i propri limiti e a raggiungere una propria coerenza personale solo grazie alla lotta contro i loro genitori per affermare se stessi e i propri punti di vista.
Imparare a vivere con il lungo ciclone dell’adolescenza
Il periodo dell’adolescenza non solo è oggi più complesso, ma fortemente protratto nel tempo a causa delle problematiche economiche e delle enormi difficoltà per i giovani di entrare nel mondo del lavoro. Gli adolescenti hanno bisogno dell’autorevolezza dei genitori e del loro riferimento rassicurante, non soltanto quando cercano, magari senza ammetterlo, protezione ma, anche e soprattutto, nei momenti di contrapposizione agli adulti.
Troppo spesso, negli ultimi anni, i genitori preferiscono assecondare i figli e diventare loro confidenti, condividendone la vita personale e le esperienze sessuali e sentimentali. Questo crea una situazione di complicità cui è difficile sottrarsi, anche perché un adolescente è gratificato dal fatto di sentirsi rassicurato da un genitore. Ma gli adolescenti – va ribadito – non hanno bisogno di genitori amici, bensì di figure di riferimento che non abbiano paura di entrare in conflitto con loro e di essere criticate e contestate da loro.
Questo non vuol dire che i genitori non debbano attrezzarsi nell’arte della negoziazione intelligente specialmente nei momenti di acceso confronto, in cui è necessario chiarire le reciproche convinzioni e posizioni per trovare possibili mediazioni. Ma di fronte al “muro” del rifiuto di una soluzione condivisibile, i genitori sono chiamati a far valere la loro autorità, anche al prezzo di deludere e scontentare il figlio.

Leggi anche:
Il difficile compito di dare delle regole agli adolescenti

Fede, speranza, carità: la parabola del figliol prodigo
Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, ebbe ad affermare che quello del genitore è un mestiere impossibile, perché nonostante i più grandi sforzi l’esito positivo non è scontato. Spesso, durante questa difficile e non breve prova, i genitori possono sentirsi delusi ed amareggiati, arrivando a credere che i loro sforzi siano vani o addirittura controproducenti. La parabola del figliol prodigo, che possiamo anche leggere come un distillato di saggezza ed ottimismo sull’adolescenza, si presta a fornire delle risposte incoraggianti anche ai genitori del terzo millennio. Quel padre che, contro la legge, concede al figlio minore che la pretende la sua parte di eredità, è solo un padre buono e magari un po’ sprovveduto, o soprattutto un padre pieno di fede e di speranza che gli sforzi e l’impegno profusi alla lunga non risulteranno vani? Egli dimostrerà infatti di avere la forza di superare il dolore e l’amarezza per la lontananza dissoluta del figlio, per riaccoglierlo generosamente a braccia aperte quando costui si renderà conto dei suoi errori e ricorderà di avere un padre misericordioso. L’autore si rivolge laicamente a questa parabola per tirare la conclusione della sua riflessione sull’adolescenza con queste parole finali:
Quasi venti secoli prima di Donald Winnicott (il famoso psicanalista inglese che tanto si è occupato di questa fase della vita), il padre del figliol prodigo scoprì che l’adolescenza è (…) un periodo tempestoso ma necessario che verrà superato. Tocca ai genitori e agli adulti sopportarla senza farsene sopraffare.
E noi cristiani possiamo chiosare questa frase senza snaturarla aggiungendo …grazie alla forza della fede, della speranza e della carità.