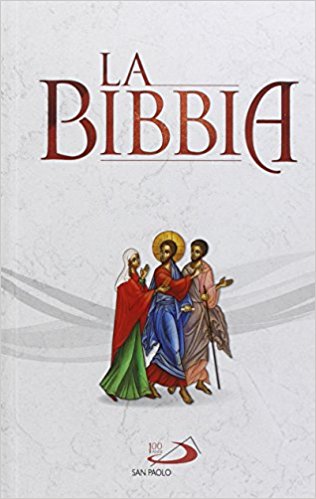Lutero e Girolamo: due miti da sfatare
Un grande (falso) mito della modernità è che Lutero sia stato il primo a tradurre la Bibbia in una lingua moderna. Un aneddoto dell’agiografia protestante atto a costruire l’epopea del Riformatore: in realtà la Bibbia si traduceva correntemente nelle lingue volgari almeno a partire dal XIII secolo, e non c’è motivo di ritenere che non lo si sia fatto già prima.
Del resto si tratta della reiterazione di un altro (falso) mito, stavolta cattolico e della tardo-antichità: che Girolamo sia stato il primo traduttore latino della Bibbia. Mito un po’ meno sbandierato di quello luterano, va detto, per la conclamata insostenibilità della tesi: Girolamo intervenne, nei suoi giorni (e nelle sue lunghe notti), proprio per dire una parola nuova in un contesto che già pullulava di traduzioni.
Figuriamoci, proprio in quel secolo la Bibbia era stata tradotta perfino in gotico… E in realtà la caratteristica dominante del libro sacro dei cristiani – oltre al fatto che si tratta di un composito di molti libri scritti in diverse epoche da autori anche estremamente eterogenei – è proprio che essa è stata tradotta. Se è vero, come m’insegnava Elmar Salmann, che un libro vive una nuova vita quando viene tradotto, allora bisogna riconoscere che la Bibbia nacque mentre già viveva le prime delle sue innumerevoli vite. Prima in greco, naturalmente, e secondo diverse versioni. Poi in aramaico, in siriaco, in latino, in gotico, in etiopico, in gaelico… e piano piano in volgare italiano, in linguadoca, in mediofrancese, in mediotedesco e in tutti gli idiomi del mondo noto, perlomeno dove il cristianesimo si era affermato.
Protestare che l’innovazione di Lutero non sta, quindi, nell’aver tradotto per primo in lingua moderna (ma semmai nell’aver per primo mutilato il canone scritturistico in età moderna), non vuole ridimensionare la portata storica della Riforma, ma appunto ricollocarla nella sua dimensione propria: Lutero e Girolamo in fondo hanno in comune il rinnovato zelo filologico per i testi ebraici.
Poi succede sempre quello che è fatale, cioè che dei grandi monumenti divengano autorità in sé, più che modello da imitare: è accaduto con la Vulgata geronimiana, divenuta per lunghi secoli “la Traduzione”; è accaduto con la Luthersbibel e ancora di nuovo accade con alcune storiche traduzioni (come la Diodati).

Leggi anche:
Basta polemiche sulla “Domenica della Parola”!
Le traduzioni italiane: una scelta (non troppo) vasta
La Bibbia di Wulfila resta un testo esoterico per gran parte dei cristiani del XXI secolo, come pure quella di Wyclif e quella di Lefèvre d’Étaples – anche se l’inglese e il francese del basso medioevo restano più comprensibili del gotico del IV secolo. Se poi ascoltiamo il Messiah di Händel o la Matthäuspassion di Bach dovremo per forza familiarizzare con la King James o con la versione di Lutero. Ma queste sono cose decisamente di nicchia: se invece volessimo scrutare il panorama italiano contemporaneo, cosa troveremmo?
Purtroppo non sono in molti ad avere le idee chiare in merito, e ciò risponde probabilmente a due concause: la prima è il diffuso affievolirsi di quella sensibilità filologica che, di fronte a una traduzione, ha sempre cura d’informarsi sull’identità, sulle idee e sugli scopi del traduttore (tradurre è sempre anche tradire, quindi vale sempre la pena conoscere l’uomo, o gli uomini, della cui versione scegliamo di fidarci); la seconda è che in realtà se oggi entriamo in una libreria italiana, anche di testi religiosi, non abbiamo una vastissima scelta, quanto alle traduzioni.
«Ma come?», obietterà qualcuno: vediamo che anche in occasione della Domenica della Parola sono state stampate delle “Bibbie apposite”, ben più di quei sussidi che ci si poteva ragionevolmente aspettare! Sì, questo è vero, ma intanto va detto che le “Bibbie apposite” sono tutte delle veloci ristampe con una nuova copertina in brossura, e che dunque in nulla differiscono da altri prodotti editoriali (non ci sarebbe neppure stato il tempo materiale di fare altrimenti, vista la rapidità dei tempi con cui l’iniziativa è stata imbastita e consumata). E poi si deve dire che, purtroppo, le traduzioni italiane contemporanee – dunque escludiamo non solo la Malermi e la Diodati, ma anche le più recenti Martini, Garofalo e Luzzi, nonché la “Civiltà Cattolica” – sono in fin dei conti tre in tutto, con poche altre varianti.
Le “magnifiche tre”
In sintesi, esse sono la CEI, la “Nuovissima versione” e la TILC:
La CEI ha curato delle traduzioni “ufficiali” soprattutto a fini di autenticità liturgica: per poter introdurre le letture nella lingua del posto, la Santa Sede ha disposto che le Conferenze episcopali elaborassero un testo – un unico testo per ogni lingua, fino al motu proprio Magnum principium di Papa Francesco, del 9 settembre scorso – e che questo testo, previa approvazione della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, venisse adottato in esclusiva nelle celebrazioni in quella lingua (d’ora in poi in quel Paese). La Conferenza episcopale italiana ha fatto questo nel 1971, anzitutto, prendendo il testo di Antonio Martini e facendolo ammodernare e abbellire, nel lessico e nella sintassi, dai letterati più in vista nell’Italia di allora. Si resero necessari dei “ritocchi filologici”, che piovvero sul testo a più riprese: nel 1974 vi fu il primo (e la “CEI ’74” è la versione che ancora oggi tutti abbiamo un po’ più nelle orecchie…); nel 1997 fu rivisto il Nuovo Testamento e nel 2008 è stata pubblicata una nuova versione, che si discosta ormai sensibilmente dalle precedenti. Tra le prime CEI e la “CEI 2008” è infatti intervenuto un forte elemento di novità, ovvero la promulgazione della Nova Vulgata, che era già pronta dal 1979 ma che solo dall’istruzione Liturgiam authenticam, del 2001, è stata fissata come paradigma di tutte le traduzioni liturgiche cattoliche al mondo. Insieme con altri elementi, l’utilizzo di questo strumento preponderante ha fatto sì che alcuni passi noti risultassero alterati anche all’orecchio del “fedele della domenica”, magari non esattamente specializzato in versioni bibliche.
Il continuo e giusto anelito a traduzioni che fossero anzitutto sempre più aderenti ai “testi originali” ha prodotto la “Nuovissima versione”, che non essendo influenzata dalla Neovulgata assomiglia molto più alle “vecchie CEI” che alle letture oggi proclamate durante la messa: tuttavia si tratta di una versione avviata all’indomani del Concilio, già nel 1967, e compiuta nel 1980 – difficile dirla ancora “nuovissima”.
Un prodotto oggettivamente interessante è la “TILC” (acronimo di “Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente”), curata da un gruppo misto di traduttori cattolici e protestanti: ha il grande pregio di riuscire a offrire al lettore un lessico e una sintassi veramente vivaci. Il lettore della TILC non ha mai la sgradevole sensazione di trovarsi di fronte a un testo in “traduttese”, cioè in quella lingua morta che con atto di falso pubblico viene dichiarata viva. Un simile pregio non è però a buon mercato: l’incalzante paratassi della TILC opera spesso forzature sintattiche di non poco conto, sui testi originali, specie sui non pochi caratterizzati da marcata ipotassi. Ciononostante, resta senza dubbio la Bibbia che consiglio a chi non ha mai letto le Scritture, a chi magari non ha interesse a imbarcarsi in questioni critiche (che specie ai neofiti possono risultare noiose e sterili)… e non vuole arrendersi esausto dopo due pagine. Di sicuro, però, non è una traduzione che si può utilizzare in esclusiva, mano a mano che ci si addentra nella conoscenza dei testi sacri.
BJ & TOB: le due celebrità francesi… all’italiana
Sicuramente qualcuno si sarà stupito che io non abbia ancora elencato la Bibbia di Gerusalemme e la TOB, che sono forse le Bibbie più conosciute e più vendute attualmente in Italia. È presto svelato l’arcano: nessuna delle due, in Italia, è stampata con il proprio testo, ma tutte e due hanno riportato la “CEI ’71” fino al 2009 (ovvero all’indomani della pubblicazione della CEI 2008, che avvenne con la prima domenica d’Avvento di quell’anno, quindi a dicembre).
Perché questo? I malevoli potranno pensare a un oscurantismo clericale duro a morire, che ancora e sempre mortifica le belle espressioni di indipendenza ermeneutica. Sono proprio la Nuovissima Versione e la TILC (ma anche le versioni ancora parziali, come la TINTI di Roberto Reggi) a dire che non sussiste una simile intenzione censoria: il problema è piuttosto di ermeneutica e di filosofia del linguaggio. Se infatti volessimo tradurre il testo della Bible de Jérusalem o della Traduction Œcuménique de la Bible (donde “TOB”) non staremmo più operando conformemente ai loro estensori, perché di fatto staremmo producendo delle comuni traduzioni dal francese in italiano. Ma il francese non è una lingua biblica… dunque che valore accademico o esegetico potrebbe mai avere un testo che risultasse da siffatta operazione?
Quindi delle due vedette dell’esegesi d’Oltralpe possiamo godere in italiano “soltanto” le introduzioni e gli apparati critici. Non è moltissimo, ma se non si parla il francese ci si può comunque accontentare di imparare tanto dagli studi dei domenicani dell’École Biblique de Jérusalem, estensori della BJ, e dalla cura esegetica dell’équipe della TOB.
Questa merita una parola a parte, perché è nata proprio a margine della Bibbia di Gerusalemme: sono stati gli stessi domenicani di Gerusalemme a rilanciare una nuova traduzione, proprio mentre terminavano l’altra, per poter sperimentare un lavoro meno vincolato in collaborazione con i membri protestanti della squadra e quelli ortodossi, la cui presenza è diventata mano a mano più significante nel corso del tempo. Da principio s’era pensato di coinvolgere nel progetto anche degli esegeti di fede giudaica, ma le problematiche che sorgevano anche da questa sola ipotesi di lavoro furono tante e tali che il progetto restò “solo” ecumenico e non divenne mai interreligioso in senso stretto.
Il lavorio e rilavorio dell’équipe della TOB è incessante, e sette anni fa sono stati inclusi nell’ultima versione perfino i libri “buoni da leggere” delle confessioni ortodosse, come 3 e 4 Esdra, 3 e 4 Maccabei, la Preghiera di Manasse e il Salmo 151 (si noterà che non sono i testi propri del canone copto, ancora mancanti anche nella TOB). Insomma, niente male per un’opera che partì con una traduzione fondamentalmente cattolico-protestante della Lettera ai Romani, che da Lutero in qua significa uno degli scogli più importanti alla piena comunione ecclesiale in Occidente.
Bibbie per tutti i gusti (e per ogni tasca)
Direi che questo sia l’essenziale da tenere a mente, se ci si chiede come fare per orientarsi tra le tante Bibbie poggiate allo scaffale della libreria. «Non saranno tutte uguali», si dirà ognuno pieno di buonsenso. E difatti non lo sono, però bisogna pure capire in che cosa differiscono, e con ciò mi pare di aver detto a sufficienza.
A margine di queste considerazioni resta tutta una galassia di pubblicazioni collaterali: non si contano più le “Bibbie per bambini”, a fumetti o con soli passi scelti; spuntano “Bibbie per i giovani” dal formato e dalla grafica accattivanti, ricche di mappe e di note (più storiche che filologiche, dato il target); e poi ci sono le “Bibbie per gli sposi”, quelle per i fidanzati e chissà quante altre (una per gli anziani non la vedrei male, con la pagina ariosa, i caratteri grandi e chiari: la presbiopia è una condizione oggettiva).
Come si vede, in simili progetti editoriali sussistono insieme ragioni comunicative e meri pretesti commerciali: è certamente bene sapere di poter valutare molte ipotesi, ad esempio per un regalo; viceversa è pure necessario non restare incantati da specchietti per le allodole – la Bibbia è un libro (un libro di libri, per l’esattezza): è fondamentalmente testo. L’essenziale è che la traduzione sia buona, che sia stampata bene, che le introduzioni e le note siano chiare e utili.
Ma soprattutto è importante avere presenti i fondamentali su come si legge la Bibbia, e mi piace riportare le parole di un’udienza di Benedetto XVI del 2007 per ricordare due grandi principî origeniani:
- la Scrittura si compone di più livelli di comprensione, che si approfondiscono mano a mano che si cresce nella Parola;
- si cresce nella Parola grazie alla lettura spirituale, che considera tutta la Bibbia sempre anzitutto profezia e testimonianza di Cristo.
[…] nella nona Omelia sui Numeri, […] Origene paragona la Scrittura alle noci: «Così è la dottrina della Legge e dei Profeti alla scuola di Cristo», afferma l’omileta; «amara è la lettera, che è come la scorza; in secondo luogo perverrai al guscio, che è la dottrina morale; in terzo luogo troverai il senso dei misteri, del quale si nutrono le anime dei santi nella vita presente e nella futura» (9,7).
Soprattutto per questa via Origene giunge a promuovere efficacemente la “lettura cristiana” dell’Antico Testamento, rintuzzando in maniera brillante la sfida di quegli eretici – soprattutto gnostici e marcioniti – che opponevano tra loro i due Testamenti fino a rigettare l’Antico. A questo proposito, nella medesima Omelia sui Numeri l’Alessandrino afferma: «Io non chiamo la Legge un “Antico Testamento”, se la comprendo nello Spirito. La Legge diventa un “Antico Testamento” solo per quelli che vogliono comprenderla carnalmente», cioè fermandosi alla lettera del testo. Ma «per noi, che la comprendiamo e l’applichiamo nello Spirito e nel senso del Vangelo, la Legge è sempre nuova, e i due Testamenti sono per noi un nuovo Testamento, non a causa della data temporale, ma della novità del senso … Invece, per il peccatore e per quelli che non rispettano il patto della carità, anche i Vangeli invecchiano» (9,4).